È l’aprile del 1980 quando la Rhodesia del Sud cambia il nome in Zimbabwe ottenendo finalmente l’indipendenza. Come spesso accade nel continente africano, anche i primi giorni dello Zimbabwe indipendente sono stati caratterizzati da tensioni e violenze.
Una Rhodesia bianca e indipendente
Colonia britannica, come il Sudafrica, anche la Rhodesia del Sud era caratterizzata da un regime di segregazione razziale guidato dalla minoranza bianca. Entrambi, infatti, erano colonie di settlers, territori dove i coloni europei non si erano limitati a insediarsi lungo le aree costiere, ma si erano spinti nell’interno avviando attività agricole e costringendo la popolazione indigena ad abbandonare le proprie terre per spostarsi nelle riserve.
Gli eredi dei coloni britannici in Rhodesia avevano annunciato l’autonomia del Paese con la Dichiarazione Unilaterale di Indipendenza (UDI) del 1965. Si trattava dell’estremo tentativo di mantenere il controllo delle risorse ed evitare la presa del potere da parte della maggioranza nera che, proprio in quel momento, stava portando all’indipendenza molti Paesi del continente. Attraverso la UDI, il governo, guidato da Ian Smith, si auto-riconosceva autorità politica e giuridica, senza però essere riconosciuto come Stato indipendente né dalla madrepatria, il Regno Unito, né della comunità internazionale.
La proclamazione dell’indipendenza spinse l’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) a sviluppare pressioni nei confronti del Regno Unito affinché non concedesse la reale indipendenza al Paese, prima di aver posto fine al regime di minoranza bianca. Se questo non fosse avvenuto i Paesi membri dell’OUA avrebbero potuto decidere di limitare le relazioni diplomatiche ed economiche con il Regno Unito.
Diplomazia e lotta armata per l’indipendenza
I negoziati che porteranno alla nascita dello Zimbabwe si protrarranno per anni, tanto che, di fronte alla situazione di impasse che si registrava nel Paese, a partire dal 1970 l’OUA decise di garantire il proprio sostegno alla lotta armata. L’appoggio, garantito dal Liberation Committee, inizialmente era destinato alla Zimbabwe African People’s Union (ZAPU), guidata da Joshua Nkomo. Ciò fino a che il radicamento territoriale della Zimbabwe African National Union (ZANU), capitanata da Rober Mugabe, non crebbe tanto da spingere anche al suo appoggio.
Parallelamente alla lotta armata ci sarà il fallimento di svariati tentativi diplomatici, guidati soprattutto dal Regno Unito, ma anche dagli Stati Uniti, che erano interessati a evitare che il Paese entrasse nella sfera di influenza sovietica. Anche la diplomazia regionale aveva tentato di inserirsi nel processo di indipendenza del Paese, ma l’incontro del 1975, a Victoria Falls, si risolse in un nulla di fatto, a causa del disaccordo tra le diverse parti coinvolte.
Il “willing seller, willing buyer” nello Zimbabwe indipendente
Sarà la conferenza di Lancaster House a dare l’indipendenza al Paese. I negoziati, tenutosi nel 1979, videro la partecipazione dei movimenti di liberazione nazionale, la ZANU e la ZAPU, del governo non riconosciuto di Muzorewa, di Ian Smith, in qualità di rappresentate della popolazione bianca, degli Stati della Linea del Fronte (SLF), in rappresentanza della diplomazia regionale e del Regno Unito in qualità di ex potenza coloniale. La firma del cessate il fuoco da parte di Mugabe e Nkomo segnò la fine della guerra civile e aprì la strada alla concessione dei diritti civili e politici alla popolazione nera. Ne conseguì lo svolgimento delle prime elezioni democratiche che nel febbraio del 1980 vedranno la vittoria della ZANU guidata da Mugabe. L’indipendenza venne proclamata ufficialmente nell’aprile del 1980.
A causa della colonizzazione europea, al momento dell’indipendenza, il 39% della terra più fertile del Paese era occupato da grandi aziende agricole di origine coloniale. Dall’altro lato, le riserve, chiamate communal lands e collocate in aree marginali, destinate alla maggioranza nera, occupavano circa il 42% del territorio. Inevitabilmente, quindi, uno dei cardini della Conferenza di Lancaster furono i negoziati sulla terra. Su pressione britannica, venne garantito alla minoranza bianca che le terre non sarebbero state riespropriate per attribuirle alla maggioranza nera, ma che sarebbero state oggetto di acquisti e vendite secondo il principio del “willing seller, willing buyer”. Gli agricoltori bianchi interessati avrebbero potuto vendere le loro terre al nuovo governo del Paese, il quale poi si sarebbe occupato di rivenderle alla popolazione. Obiettivo dell’accordo era evitare un processo di espropriazione violenta, portato avanti dalla popolazione locale, con l’obiettivo di “vendicarsi” delle violenze subite durante la colonizzazione. Inoltre, il Regno Unito avrebbe “risarcito le proprie colpe coloniali” grazie alla fornitura dei fondi necessari per l’acquisto delle terre.
La costruzione di uno Stato autoritario
Subito, però, la riforma non venne portata avanti secondo gli accordi. Le terre acquistate, infatti, vennero distribuite alle reti clientelari di Mugabe e della ZANU, piuttosto che al resto della popolazione. Inoltre, a causa delle frequenti violazioni dei diritti umani e delle violenze commesse dal governo, il Regno Unito cessò rapidamente i finanziamenti per l’attuazione della riforma.
Fin dalla salita al potere, infatti, Mugabe e la ZANU cercarono di consolidare il proprio potere in modo autoritario. Il governo di unità nazionale, formatosi al momento dell’indipendenza, tra ZANU E ZAPU ebbe vita molto breve. La rottura dell’alleanza governativa fu affiancata dall’avvio di un conflitto civile nel Matebeleland dove la ZAPU aveva la maggior parte del proprio consenso. La guerra, che si protrarrà fino all’87, non era altro che la conclusione della lotta per la leadership tra i due movimenti di liberazione e fu caratterizzata da atroci violenze. L’esercito nazionale, infatti, su ordine del governo attuò dure repressioni nei confronti dei civili, causando tra le 10 mila e le 20 mila vittime. La risoluzione delle tensioni tra i due partiti giunse solamente con la firma dello Unity Accord, che sanciva la fusione di ZANU e ZAPU e la nascita della ZANU-PF. Veniva così a meno l’unico partito che fino a quel momento era stato in grado di svolgere una reale opposizione nel Paese. Lo Zimbabwe si avviava, così, verso un sistema a partito unico, facilitato dall’assenza di una reale opposizione, nonostante il mantenimento di elezioni multipartitiche.
Fonti e approfondimenti:
Pallotti A., Zamponi M., L’Africa Sub-sahariana nella politica internazionale, Le Monnier, 2010, pagine 45-47, 91-94, 120-128
Pallotti A., Alla ricerca della democrazia. L’Africa Sub-sahariana tra autoritarismo e sviluppo, Rubettino, 2013, pagine 98-118, 197-207
Grafica: Marta Bellavia – Instagram: illustrazioninutili_
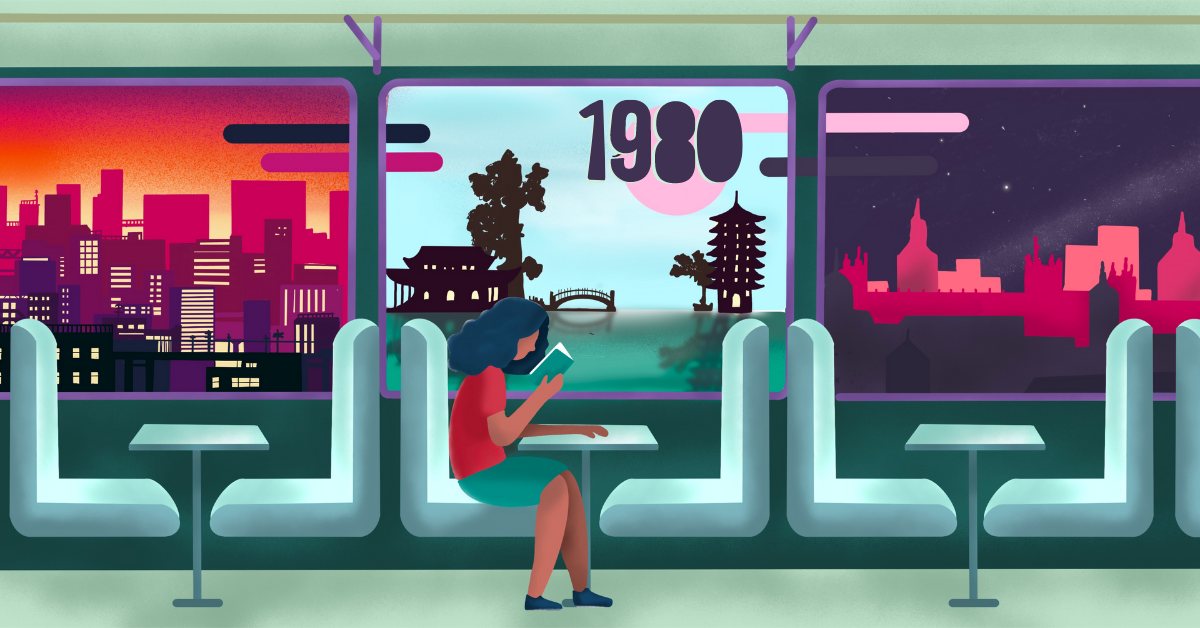


Rispondi