La Cecenia è una piccola repubblica autonoma della Federazione Russa, ricca di petrolio, incastonata fra le montagne del Caucaso Settentrionale. Le rotte di accesso al Mar Nero e al Mar Caspio che l’attraversano, così come i collegamenti petroliferi, la rendono una regione di importanza strategica vitale per la Russia.
Tuttavia, questo minuscolo granello dello Stato più vasto del mondo è sempre rimasto aggrappato con le unghie e con i denti alla propria indipendenza, così come alle proprie tradizioni culturali e religiose (la maggior parte della popolazione professa l’Islam sunnita sufista). Ancora oggi, i ceceni si salutano appellandosi al loro valore più alto: “Che la libertà sia con te!”.
Uno spirito di ribellione che la Russia ha sempre represso con il pugno di ferro per evitare qualsiasi contagio, dall’epoca zarista a quella sovietica, fino ad arrivare ai giorni nostri. Da più di tre secoli, le guerre cecene vengono citate come “esempio per tutta la nazione”: anche Vladimir Putin presentò così la propria spedizione militare esattamente vent’anni fa, nel 1999, quando dichiarò di nuovo aperte le ostilità e diede avvio all’assedio di Groznyj.
Le radici del secondo conflitto
Approfittando del momento di massima debolezza dell’autorità centrale, nell’autunno 1991, l’ex generale dell’aviazione Džochar Dudaev, forte del sostegno popolare, dichiarò unilateralmente l’indipendenza della Cecenia dalla neonata Federazione Russa. Così, nell’estate del 1992, quella che fino ad allora era stata la Repubblica Autonoma Ceceno-Inguscia si divise: l’Inguscezia aderì subito al Trattato di Federazione con la Russia; la Cecenia, invece, proclamò la propria piena indipendenza come Repubblica Cecena di Ichkeria nel 1993.
Iniziò una guerra civile intestina fra russi e ceceni, inframmezzata da diversi tentativi falliti di rovesciare il governo ribelle da parte della Federazione. La situazione si deteriorò inesorabilmente, fino ad arrivare allo scontro aperto nel 1994. Quella che venne presentata come una “guerra lampo”, finì per durare due anni e per contare decine di migliaia di morti e feriti da entrambe le parti: la prima guerra cecena si rivelò il “Vietnam” della Russia.
Alla fine, i separatisti riuscirono a riprendersi Groznyj, la capitale, e si arrivò al “cessate il fuoco” il 31 agosto 1996, con la firma degli accordi di Khasav-Jurt fra il generale russo Aleksandr Lebed’ e il capo di stato maggiore ceceno Aslan Maschadov. L’esercito russo si ritirò immediatamente dalla Cecenia, che rimase di fatto indipendente. Appena eletto presidente della repubblica (Dudaiev era stato ucciso da un missile russo nel ’95), Maschadov siglò il trattato di pace con Mosca nel 1997. Una pace che, tuttavia, non era destinata a durare.
Il nuovo governo autonomista, stanziato nella semidistrutta Groznyj, perse velocemente il controllo sul resto del Paese. I capi rissosi dei teip (i clan della società cecena) tornarono a spadroneggiare, a cui si aggiunsero i nuovi “signori della guerra”, banditi e fondamentalisti islamici, a volte stranieri. In Cecenia, infatti, iniziò a diffondersi il wahhbismo, visione radicale sunnita in aperto contrasto con la tradizione cecena: anche Šamil Basayev, “eroe della nazione” della prima guerra, finì col fare l’ingresso nei suoi ranghi.
Fu proprio Basayev, insieme all’emiro saudita Ibn al-Khattab (figura controversa che aveva sposato la causa cecena durante il primo conflitto, al comando di un manipolo di mercenari fanatici), che organizzò un’incursione nella vicina repubblica del Daghestan, nell’estate del 1999. L’obiettivo era quello di dare una mano ai separatisti locali in lotta contro la Federazione, e creare un unico grande Stato islamico nel Caucaso. Il risultato di questa spedizione fu la sconfitta dei ribelli che fornì il pretesto perfetto al Cremlino per riprendere le ostilità. Questo, unito a delle bombe scoppiate in alcuni palazzi di Volgodonsk e di Mosca, fu la miccia che fece scoppiare la seconda guerra cecena a fine agosto del 1999.
Il “vortice anti-terrore” di Putin
A questo punto fece il proprio ingresso nella storia un colonnello all’epoca ancora semi-sconosciuto all’opinione pubblica russa, che era a capo del FSB (i servizi segreti federali) dal 1998: Vladimir Putin. Proprio in concomitanza con la recrudescenza del conflitto nel Caucaso Settentrionale, il presidente El’cin lo nominò primo ministro della Federazione, nella speranza che presto potesse diventare il suo successore.
Putin si presentò subito come un uomo d’ordine, con un approccio alla guerra piuttosto pragmatico. “Noi perseguiteremo dappertutto i terroristi, e quando li troveremo – mi perdoni l’espressione – li butteremo dritti nella tazza del cesso”, dichiarò ai giornali il nuovo primo ministro a proposito dei guerriglieri ceceni, nel settembre 1999. La nuova guerra, infatti, venne presentata dai russi come una “operazione anti-terrorismo nel Caucaso del Nord”, soprannominata “vortice anti-terrore”. La popolarità di Putin fra le masse schizzò alle stelle, spianandogli la strada per le elezioni presidenziali nel marzo del 2000.
Diversi capi clan ceceni si allearono con il Cremlino, tra cui Akhmad-Khaji Kadyrov, ex gran mufti (massima autorità in materia di legge religiosa islamica) che durante la prima guerra istigava i propri connazionali al jihad contro la Russia. Per ricompensarlo del suo cambiamento di rotta, Putin lo nominò capo della nuova amministrazione provvisoria di Groznyj nel luglio del 2000, dopo aver rovesciato Maschadov (ucciso poi dai russi nel 2005).
Una delle più grandi tragedie contemporanee
Nelle intenzioni di Putin, la seconda guerra cecena sarebbe dovuta durare al massimo 4 mesi. Finì per essere più lunga del secondo conflitto mondiale, e più sanguinosa dello scontro del 1994. Si parla di non meno di 100.000 vittime civili, di cui circa 31.000 sono bambini rimasti mutilati o con invalidità permanenti. Senza contare le diverse decine di migliaia di profughi russi e ceceni che hanno dovuto abbandonare, a più riprese, la regione.
Lungi dal pacificare la zona, l’esercito federale iniziò a commettere atti di brutalità e violenza inimmaginabili, in aperto contrasto con le norme del diritto internazionale e dei diritti umani. Attacchi massicci ai civili con utilizzo di artiglieria pesante, esecuzioni sommarie, maltrattamenti, torture, stupri, rapine. Moltissime persone catturate dai militari russi scomparirono senza lasciare traccia. L’assedio e la conquista di Groznyj da parte dei federali ridussero la città in condizioni tali che le Nazioni Unite la elessero “città più devastata del mondo” nel 2003. L’orrore divenne una realtà quotidiana con cui fare i conti.
Emblematico fu il caso del colonnello russo Jurij Budanov che, nella notte fra 26 e 27 marzo 2000, rapì, torturò, stuprò e infine uccise la diciottenne cecena Elza Kungaeva. Il colonnello sostenne di aver prelevato la giovane dal villaggio di Tangi-Chu, nel distretto di Urus-Martan, perché sospettata di collaborare con la guerriglia, addirittura di essere una cecchina. Ma non c’era assolutamente nessuna prova al riguardo. Il processo a Budanov fu lungo e molto combattuto, con il ministero della Difesa che lo difese a spada tratta: alla fine, il militare venne condannato a 10 anni di carcere per rapimento, abuso d’ufficio e omicidio (l’accusa di stupro venne ritrattata, ma per i ceceni è un crimine peggiore dell’omicidio). Anche se Budanov è stato in seguito rilasciato dal carcere 15 mesi prima del previsto, il suo è stato uno dei primi casi in cui le autorità russe hanno riconosciuto pubblicamente un crimine di guerra commesso dai federali.
Alla brutalità si rispose con altra brutalità, e la reazione dei ceceni non si fece attendere. La guerra entrò in casa dei russi. Il 23 ottobre 2002, una quarantina di combattenti ceceni (fra cui anche alcune donne, un dettaglio importante data la scarsa emancipazione di cui godono nella tradizione cecena) prese in ostaggio 916 persone all’interno del teatro Dubrovka di Mosca, durante la prima del musical Nord-Ost. La richiesta che i terroristi rivolsero al Cremlino era “semplice”: porre fine alla guerra. Il 26 ottobre, dopo 57 ore di sequestro, le autorità russe immisero nel teatro un’arma chimica segreta (a causa della quale morirono anche 130 ostaggi), e i terroristi vennero trucidati mentre erano privi di sensi.
La “cecenizzazione” e l’espansione dello scontro
Già a partire dall’estate del 2000, il governo centrale decise di iniziare a impiegare le autorità cecene filorusse per reprimere la guerriglia indipendentista. Iniziò, così, la “cecenizzazione” del conflitto. Dopo il tragico episodio del Dubrovka, in particolare, il Cremlino decise di puntare tutto su Akhmad Kadyrov.
Il 23 marzo 2003, un referendum nazionale in Cecenia approvò con il 95% dei voti una nuova Costituzione, che riconosceva a Mosca il potere di sciogliere il parlamento liberamente eletto dai cittadini. Venne annunciato ufficialmente “l’ingresso volontario della Cecenia nella Federazione Russa”. Il 5 ottobre successivo, si svolsero le “elezioni del primo presidente” della repubblica, rispetto alle quali l’OSCE e molte ONG denunciarono brogli elettorali: Akhmad Kadyrov vinse al primo turno con una maggioranza schiacciante. All’epoca, aveva già creato il proprio esercito privato di circa 5.000 soldati, detti kadyrovcy.
Nel giro di pochi mesi, però, Akhmad rimase ucciso in uno degli attacchi terroristici delle cosiddette “vedove nere”, le donne kamikaze cecene. Suo figlio, Ramzan Kadyrov, prese velocemente il suo posto, diventando governatore de facto della repubblica fino alla sua elezione a presidente nel 2007 (carica che detiene tutt’ora).
Le “strutture di sicurezza non inquadrate della Cecenia”, ossia le bande armate che facevano capo ai diversi “signori della guerra” ceceni, trasformarono sempre di più il conflitto in una guerra civile. Il fronte separatista si spaccò: da una parte, gli occidentalisti, capeggiati da Maschadov, che guardavano speranzosi all’Europa dei diritti umani per salvaguardare il proprio secolare “vivere alla cecena”; dall’altra, il “partito arabo” di Basayev e al-Khattab, desideroso di legare il destino della repubblica all’Oriente arabo (per attrarre da esso ingenti investimenti) e instaurare l’Islam wahhbita al posto delle vecchie tradizioni.
Nel vuoto lasciato fra queste due fazioni, emerse una “terza forza” composta da combattenti ceceni che avevano deciso di imbracciare le armi come reazione all’anarchia e all’arbitrio dell’esercito russo. Tutto quello che interessava loro era vendicare i torti subìti, non importava se chi li aveva commessi nei loro confronti fosse russo o meno. Erano pronti a tutto: ad abbattere elicotteri, a fare attentati dinamitardi e, soprattutto, a morire.
Così, fra 2002 e 2007, la guerra si estese dalla Cecenia alle repubbliche caucasiche vicine, ossia Inguscezia, Daghestan, Ossezia del Nord e del Sud. Un eclatante episodio di violenza fu la strage di Beslan, nell’Ossezia del Nord, dove una trentina di terroristi ceceni occupò la scuola n.1 fra l’1 e il 3 settembre 2004, durante la cerimonia di apertura dell’anno scolastico. Gli ostaggi furono circa 1.200, fra bambini, genitori e insegnanti. L’irruzione delle forze speciali russe, al terzo giorno di sequestro, segnò l’inizio di una carneficina che portò a 330 morti (di cui 186 bambini) e oltre 700 feriti.
Se fino a quel momento il resto del mondo poteva aver guardato con comprensione alla causa cecena, questa ennesima tragedia trasformò i “combattenti per la libertà” in “terroristi islamici” anche sui media occidentali. Non che la comunità internazionale si fosse sbilanciata sulla questione più di tanto: l’Europa lasciò campo libero a Putin in nome della sua guerra santa contro il terrorismo. Schröder, Blair e Berlusconi furono fra i leader che dimostrarono apertamente grande supporto verso il presidente russo.
D’altronde, era molto difficile fare informazione sulla Cecenia, soprattutto per i giornalisti russi. Oltre a escludere dalla regione i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, infatti, il Cremlino tagliò fuori buona parte dei mezzi di informazione. Lo sapeva bene la giornalista Anna Politkovskaja, indomita reporter della Novaja Gazeta assassinata da ignoti a Mosca il 7 ottobre 2006, poco prima di pubblicare la sua ultima inchiesta sulle torture a cui aveva assistito nel Caucaso.
Le conseguenze
Nel 2009, Putin dichiarò l’”operazione anti-terrorismo” in Cecenia conclusa vittoriosamente. Tuttavia, i crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani commessi in suo nome sono rimasti impuniti. Si può dire, quindi, che la guerra è veramente finita? Ad oggi, la situazione nel Caucaso Settentrionale non è migliorata, anzi. Gli attacchi terroristici non si fermano, e il Daghestan è diventato un focolaio di fondamentalismo islamico.
Una nuova generazione di nemici di Mosca – erede di quella gioventù cecena il cui destino è stato segnato dalla violenza dei federali – dal 2007 combatte per l’espansione nella regione del famigerato Emirato del Caucaso, lo Stato islamico fondato dall’ex presidente dell’Ichkeria Dokka Umarov diventato ormai un bacino di reclutamento dell’Isis.
Inoltre, le guerre cecene, soprattutto la seconda, hanno rimodellato la Russia post-sovietica in maniera indelebile. La “pacificazione” della Cecenia è il successo che ha portato Putin alla ribalta, permettendogli di costruirsi un consenso interno sulla nostalgia dei grandi Imperi, sovietico e zarista, mentre stringe la morsa sulla sua “verticale del potere” (ossia, la scala gerarchica di stretta subordinazione tra potere presidenziale e regioni russe). Invece di uno sviluppo pacifico, la Federazione di Putin negli ultimi anni ha fatto dell’espansione esterna la propria priorità – basti pensare alla breve guerra contro la Georgia nel 2008, o all’annessione della Crimea nel 2014.
Fonti e approfondimenti
Politkovskaja, A., “Proibito parlare. Cecenia, Beslan, Teatro Dubrovka: le verità scomode della Russia di Putin.”, Piccola Biblioteca Oscar Mondadori, gennaio 2007
Politkovskaja, A., “Cecenia – Il disonore russo.”, Documenti Fandango Libri, Roma, 2003
Politkovskaja, A., “La maledizione della Cecenia.”, Internazionale, 09/09/2004
Mirovalev, M., “Chechnya, Russia and 20 years of conflict.”, Al Jazeera, 11/12/2014
Loi, M., “L’Emirato del Caucaso: il terrorismo islamico che spaventa la Russia.”, 19/01/2014
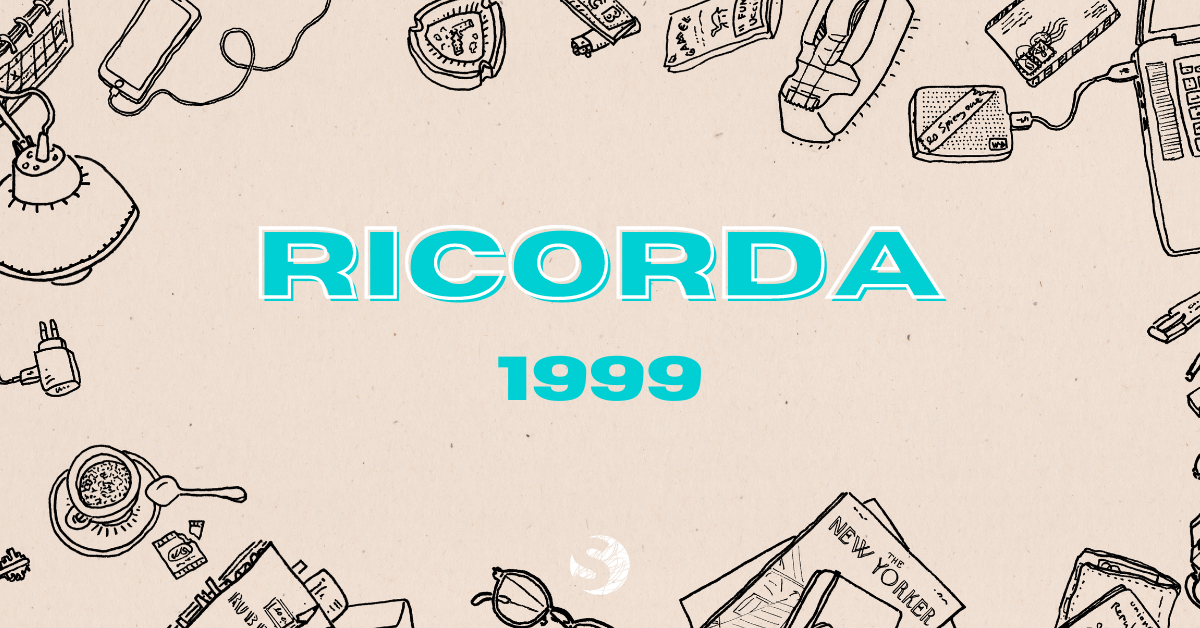


Rispondi